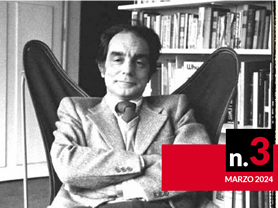Repubblica-La pietà a distanza
ILVO DIAMANTI A SAN Giuliano, straziata dal terremoto, a frugare tra le macerie, a scoprire, uno dopo l'altro, i corpi inerti delle piccole vittime. C'eravamo anche noi. Pochi minuti dopo la prima...


ILVO DIAMANTI
A SAN Giuliano, straziata dal terremoto, a frugare tra le macerie, a scoprire, uno dopo l'altro, i corpi inerti delle piccole vittime. C'eravamo anche noi. Pochi minuti dopo la prima scossa. A guardare, dolenti, la scuola crollata. Tra i parenti, gli amici, la gente del paese. Anche noi, coinvolti dalla loro disperazione. I nostri occhi: le telecamere. La nostra voce: i giornalisti delle tv pubbliche e private. I telesalotti allestiti in fretta, raccogliendo sismologi, ministri ed ex ministri, altri giornalisti, testimoni d'altri terremoti. E l'indomani sapevamo tutto. Ce l'avevano narrato i cronisti dei quotidiani. Accorsi numerosi nella piccola comunità, nel piccolo paese del Molise, lacerato dalle scosse ininterrotte.
A casa nostra, spettatori del dramma. Anche questa volta. Come altre volte. Nei giorni scorsi, alle pendici dell'Etna. Nella banlieu di Catania. E una settimana fa, a Mosca. Davanti al teatro pieno di gente, occupato dal commando ceceno. In attesa dell'esito. Tragico. Poi sospesi, fra sollievo e pena e rabbia, per quei civili, vittime del gas usato dall'unità speciale russa. Ma anche per l'immagine dolente delle donne in burqa nero, foderate di esplosivo. Immobili. Senza vita. C'eravamo anche noi. E ci siamo, ci saremo anche noi. Sempre più spesso. Ad assistere, coinvolti e impotenti, impotenti ma coinvolti, ad altri episodi drammatici. Spettatori della morte in diretta. In mezzo al pubblico numeroso dei talk show dedicati alle tragedie della nostra vita quotidiana. Perché la globalizzazione, forse più ancora che ai processi di mercato, riguarda la comunicazione. L'importanza che hanno assunto i media nella formazione del nostro orizzonte cognitivo e di valore. Un tempo potevamo anche non sapere. O comunque, non vedevamo. Eravamo risparmiati dalle onde emotive sollevate dalle molteplici tragedie che costellano il nostra tempo, il nostro mondo. Oggi nessuno più ha il privilegio dell'ignoranza. Perché tutti noi "sappiamo". Le tragedie ci raggiungono a casa nostra. Sollecitano i nostri sentimenti, la nostra curiosità.
È, secondo una definizione del sociologo Luc Boltanski, lo "spettacolo della sofferenza". Lo "spettacolo del dramma". Nel senso che la sofferenza e il dramma altrui ci vedono "spettatori" d'una rappresentazione continua, chiamati a esprimere (sempre con le parole di Boltanski) una "pietà a distanza". Una "solidarietà a distanza". Una "partecipazione a distanza". Ma è davvero possibile questo esercizio emotivo e morale? È possibile promuovere, da "spettatori partecipi", la solidarietà dentro a una scena mediatica dilatata, che fa del dolore un messaggio fra i più attraenti, per il pubblico?
La questione non è pleonastica. E non c'importa sollevarla per ripetere il rito stucchevole della critica alla tivù del sentimento e del dramma umano. Perché, davvero, la questione è ambigua, ambivalente. Corre lungo un crinale sottile.
Da un lato, la presenza pervasiva dei media costituisce un mezzo che allarga il controllo e la partecipazione; e che promuove attenzione e intervento nei confronti delle molteplici emergenze del nostro tempo, vicine e lontane da noi.
La visibilità data dai media alle situazioni di violenza o repressione a Timor Est piuttosto che in Cecenia, in Iraq piuttosto che in Sierra Leone, in Kosovo o in Palestina piuttosto che in Israele, è garanzia di controllo dell'opinione pubblica mondiale (occidentale). Esercita pressione sui governi e/o sui regimi coinvolti in queste vicende. Tutela e cautela, per quanto limitatamente, le persone e i gruppi sociali sottoposti a pericolo e violenza.
Peraltro, i riflettori puntati sulle tragedie prodotte da eventi naturali o da accidenti umani, ultimo il terremoto che ha sconvolto il Molise, suscitano pietà ed emozione. Stringono il Paese attorno al paese. Agiscono come incentivo al soccorso, all'intervento delle autorità e delle istituzioni. E favoriscono la verifica delle responsabilità e dei responsabili.
Anche a Mosca, la presenza dei media, l'attenzione pubblica interna e internazionale, dopo il momento d'iniziale approvazione dell'intervento delle forze speciali, hanno sollevato il problema dei mezzi impiegati. E del silenzio delle autorità pubbliche e militari sulla natura e sui gas utilizzati, nei confronti degli stessi medici chiamati a curarne le conseguenze sulle vittime civili.
Lo spettacolo del dolore e della sofferenza, in questo modo, appaiono contestuali al formarsi d'una sensibilità "globale"; d'una "solidarietà a distanza"; d'un "controllo differito" ("mediato" e "mediatico"), che contribuiscono a rendere più rapido ed efficace l'intervento sulle emergenze individuate.
Tuttavia, c'è un altro punto di vista, al proposito. Difficile da trascurare. La "mediatizzazione della sofferenza", l'infinito "spettacolo del dolore" a cui assistiamo, tende a renderci, sempre più, spettatori in-differenti. Perché sollecitati emotivamente, con frequenza crescente, da casi sempre diversi (guerre, attentati, terremoti, carestie, episodi di violenza quotidiana), usando toni e argomenti ogni volta più estremi, per tenere alta l'attenzione del pubblico; per attrarre gli spettatori.
La riproduzione infinita dell'emozione e della pietà, tuttavia, tende a omologare la percezione dei problemi; e, alla lunga, tende a raffreddare anche le passioni. Perché non possiamo, di continuo, esser aggrediti dalla rappresentazione del dolore, senza cadere nella tentazione di "staccare la spina", per sottrarci all'angoscia; senza correre il rischio, in alternativa, d'assuefarci, progressivamente. Diventando osservatori disattenti (anche se curiosi) del dolore (altrui).
Peraltro, l'esercizio della "solidarietà a distanza" rischia, alla lunga, di promuovere "partecipazione passiva", se ci si passa contraddizione in termini. Perché si tratta d'un atteggiamento attivato da chi gestisce la comunicazione. Da chi, per scelta o, più di frequente, per le logiche stesse della comunicazione, sposta, di volta in volta, il fuoco del riflettore. Spostando, nel contempo, il fuoco dell'emozione. Ieri sull'Iraq e sulla Cecenia, oggi su San Giuliano, domani chissà. Una partecipazione eterodiretta e delegata. Che si riproduce attraverso i riti della tele-solidarietà, come le diverse maratone televisive finalizzate a raccogliere fondi a favore di buone cause e d'istituzioni sicuramente importanti e affidabili. Ma che rafforzano l'abitudine all'impegno per delega. Mediatica. Ci spingono a essere solidali, partecipi, impegnati, caritativi: senza uscire di casa. Senza staccare gli occhi dallo schermo e le dita dal telecomando.
È, per usare una formula suggestiva di Hannah Arendt, la "politica della pietà". Dove la "pietà" si distingue dalla "compassione", perché la pietà si nutre di emozioni forti, di parole. Di casi "esemplari". Ma ci vede distanti dal luogo e dalle persone che soffrono. Distanti e distinti. Mentre la compassione ha fine "pratico". È condivisione "operativa". Non è loquace e "chiacchierona". È "muta". Si traduce in comportamenti concreti, localizzati, piuttosto che in discorsi esemplari.
Ecco: per San Giuliano, per la tragedia che l'ha colpito e il dolore che ne lacera la comunità, dopo tanta "pietà a distanza" mi sentirei di chiedere un po' di "compassione".