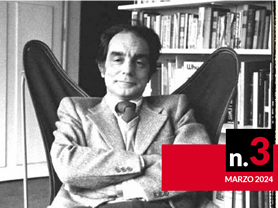La spending review? In Italia si è fatta (e male) solo per l’università
Nessun altro settore pubblico ha subito dal 2008 a oggi tagli simili (pari a un quinto) sotto tutti i governi: da Berlusconi a Renzi. Mentre gli altri Paesi invece investivano fortemente sul capitale umano. Risultato? Siamo ultimi in Europa per giovani laureati


di Gianfranco Viesti*
Si dice che in Italia non si riesca a realizzare la spending review. Il caso dell’università rappresenta una parziale smentita. Parziale, perché certamente c’è stata certamente minor spesa: una taglio fortissimo; ma è assai dubbio che ci sia stata e ci sia, miglior spesa. Le vicende degli ultimi anni dell’università italiana non sono facili da ricostruire: sono leggibili solo mettendo insieme tanti numeri, tanti decreti, tante decisioni tecniche estremamente complesse. Ma se si traduce tutto questo materiale in una fotografia d’insieme (come si è provato a fare nel volume «Università in declino. Un’indagine sugli atenei italiani da Nord a Sud», Donzelli Editore), emergono con chiarezza grandi scelte che sono state compiute e grandi interrogativi che ne scaturiscono; sia sul futuro delle università sia, più in generale, sulle prospettive della ricerca scientifica e della formazione superiore nel nostro paese.
Mamma, mi si è ristretta l’università: di un quinto
Almeno due sono le scelte di fondo che sono state compiute, che è possibile documentare, e che aprono grandi questioni. In primo luogo, tutti i dati mostrano che l’Italia ha compiuto a partire dal 2008 un forte disinvestimento sull’università. L’istruzione superiore italiana è diventata, in pochi anni, più piccola di un quinto: di tanto si sono ridotti gli studenti, i docenti, il personale tecnico-amministrativo, i corsi di laurea, i finanziamenti. Un taglio molto maggiore rispetto a qualsiasi altro ambito dell’intervento pubblico. Una dinamica che non ha riscontri negli altri paesi, avanzati e emergenti: che, a partire dalla Germania hanno aumentato in misura rilevante il proprio investimento nell’università. Una contrazione, peraltro, che si è determinata a partire da dimensioni molto inferiori; al contrario di quanto avviene per la scuola, l’Italia ha sempre investito poco sull’università; ha sempre avuto meno studenti e meno laureati. Invece di restringersi, il solco si sta approfondendo. L’Italia è oggi ventottesima sui 28 paesi europei per la percentuale di giovani (30-34 anni) che ha raggiunto la laurea; la stessa Turchia ci sta superando. Anche le nostre regioni più ricche e avanzate hanno percentuali di molto inferiori non solo rispetto ai territori forti dell’Unione, ma anche a quelli relativamente più deboli. Avere più iscritti all’università non garantisce che riescano a laurearsi: l’università italiana ha un rilevantissimo problema di abbandoni (e ritardi) su cui occorre riflettere e intervenire; allo stesso tempo avere più laureati non garantisce che essi riescano a lavorare, e non siano invece costretti ad emigrare. Ma questo dovrebbe suggerire di lavorare sull’organizzazione dei corsi di studio (per evitare gli abbandoni e renderli più adatti alle richieste del mercato) e sulla domanda di lavoro delle imprese (per spingerle ad assumere più laureati, dotandosi così di migliore capitale umano), non certo di ridurre le immatricolazioni, come invece sta avvenendo; grazie anche al forte aumento delle tasse universitarie e a modestissimi interventi per il diritto allo studio.
Meno soldi per tutti, ma più tagli per alcuni (Centro-Sud)
In secondo luogo, la forte contrazione dell’università italiana è stata selettiva tra sedi, ed ha colpito in misura molto più accentuata gli atenei del Centro-Sud. Questo, si dice, è avvenuto perché «viene premiato il merito». In realtà, se si studiano con attenzione i processi e i parametri in base ai quali sono state prese le decisioni allocative, emergono grandissimi dubbi. Non abbiamo assistito ad un processo valutativo, sulla base di indicatori chiari, definiti in partenza, raggiungibili; in base ai quali le università erano chiamate a misurarsi per poi ricevere i relativi «premi». Le risorse per gli atenei sono state decise in base a 22 diversi indicatori in sette anni, che sono cambiati tutti gli anni, e che sono stati sempre definiti dopo che i comportamenti che volevano misurare si erano già avuti; e che hanno avuto la funzione non di premiare, ma di ripartire in maniera asimmetrica risorse per il funzionamento ordinario in forte riduzione. Molti indicatori, più che alla qualità e al merito delle università, sono stati e sono ancora oggi relativi ai contesti in cui esse sono insediati: alla ricchezza delle famiglie (e al gettito delle tasse universitarie); alle competenze in entrata degli studenti. Un processo, insomma, estremamente discutibile: fino all’ultimo caso, di pochi giorni fa, in cui sono stati allocati nuovi ricercatori agli atenei. In parte, in numero uguale per tutti, con un gratuito premio ai più piccoli. Tutte scelte su cui sarebbe opportuna una discussione tecnicamente fondata, rifuggendo da facili slogan.
Se l’Italia sposa il modello inglese
L’aspetto più interessante per tutti i cittadini, infine, è che questa linea di politica universitaria così netta è stata seguita da tutti gli ultimi governi, indipendentemente dal loro colore politico: inaugurata da Berlusconi, proseguita da Monti e Letta, rafforzata da Renzi. Come se su questi temi non ci fosse che un «pensiero unico» semplicemente da mettere in atto. Che sta portando il nostro paese ad assomigliare per molti versi alla situazione, estrema, dell’Inghilterra; differenziandosi da tutti gli altri paesi europei con cui normalmente ci confrontiamo. L’università italiana, come molte (se non tutte) le istituzioni del nostro paese, ha colpe da farsi perdonare; e molto da lavorare per migliorare. E’ chiamata, in un quadro di risorse scarse, ad accrescere la propria efficienza. Ma non è che sta avvenendo: sta diventando più piccola, ma non migliore; sta accentuando squilibri fra sedi; sta riducendo la sua capacità di contribuire allo sviluppo, attraverso la formazione dei giovani, la ricerca, il trasferimento di conoscenze e saperi alle imprese e alla società. Non sta cambiando qualche dettaglio; è in corso una svolta profonda, in una direzione molto diversa rispetto agli scorsi decenni. E’ questo il modo migliore per preparare il nostro paese ad una competizione internazionale sempre più serrata, e sempre più basata sulle competenze e le capacità dei giovani? Per rafforzare tutti i suoi territori, mettendoli in grado di contribuire al benessere nazionale? Per ridurre le disparità fra gli individui e le loro famiglie, grazie alle possibilità offerte da più elevati livelli di istruzione? C’è molto da dubitarne.
*professore di Economia presso l’Università di Bari