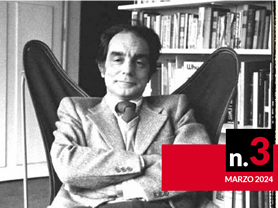La didattica digitale va compresa, prima di essere attivata
Se oltre a ricorrere agli strumenti digitali, non modifichiamo almeno in parte anche il nostro linguaggio e il nostro lavoro didattico, modellando con padronanza sempre maggiore la dimensione della connettività in base alle nostre esigenze pedagogiche, rischiamo di perseverare nel voler “dire la messa in latino”: tutti l’ascoltano e la rispettano, ma nessuno la capisce.


Carlo Sconamiglio
Marco Gui è probabilmente uno dei più attenti osservatori delle dinamiche sociali innescate dai nuovi media digitali. Una curiosa circostanza ha fatto sì che desse alle stampe, proprio alla vigilia del tragico 2020, un volumetto di grande interesse. Circa un anno fa, infatti, veniva pubblicata una sua accurata riflessione, per la casa editrice Il Mulino, con il titolo: Il digitale a scuola. Rivoluzione o abbaglio?
Al di là della raffinata qualità della scrittura e di una non frequente profondità d’analisi tra chi si occupa di temi educativi, il libro di Gui ci traghetta nel cuore di una discussione oggi diventata ancora più pregnante, alla luce dell’accelerazione obbligata, in termini di didattica digitale, determinata dalla pandemia. Gli attribuisco un merito in particolare: quello di ragionare su un tema apparentemente ovvio in modo seriamente critico, mai pregiudiziale, capace di mettere sul tappeto luci e ombre di una trasformazione in atto, che va capita, prima di essere contrastata o cavalcata.
La prima questione posta da Gui nel suo ampio ragionamento è connessa alla funzione sociale della scuola. Tutti pensano di poter intervenire sul tema senza pazientare nell’analisi; quindi correttamente – da sociologo – l’autore cerca un punto di partenza nella tradizione, nella struttura politica e culturale, che nella modernità ha delineato un sistema di regole, relazioni e processi da noi oggi definito – appunto – “scuola”, quale “luogo di trasmissione del cosiddetto ‘sapere organizzato’, cioè le conoscenze colte e strutturate nelle istituzioni formative. Questo tipo di sapere si basa sulle logiche della linearità e consequenzialità argomentativa”[1]. Probabilmente, ricorda l’autore, è una modalità di concezione del processo di apprendimento configuratasi in concomitanza con la diffusione della carta stampata. Nel mondo greco, infatti, prevaleva l’insegnamento orale, anche per piccoli gruppi, entro i quali gli esempi ermeneutici e gli esercizi mnemonici avevano parte importante.
La copiatura a mano, assai diffusa nei secoli successivi, prevedeva una graduale ristrutturazione del processo d’apprendimento. Ma è stato il libro stampato, nella molteplicità delle copie possibili, a definire grado a grado la natura delle dinamiche formative[2]. È un oggetto straordinariamente versatile, ma che intrinsecamente ha una sua struttura organizzata, e una sua linearità. Due caratteristiche divenute elementi cruciali del processo di apprendimento, nei secoli identificato con la capacità di recuperare in modo strutturato il patrimonio di sapere della propria civiltà. Un lavoro faticoso, lo studio, perché – come scrive Alessandro Baricco – non è naturale per il cervello umano procedere in modo organizzato e lineare. Il noto scrittore, infatti, in un suo fortunato libro[3] dedicato alla società digitalizzata, ha riflettuto su come la linearità e la consequenzialità, che ci sforziamo di insegnare a scuola, sull’onda lunga della nostra tradizione logica, non sono così naturali come sembrano. Dobbiamo mantenere un forte autocontrollo per rimanere concentrati e sviluppare un ragionamento rigoroso. Per sua natura, il pensiero sarebbe costantemente ondivago, stimolato da eventi interni (emozioni) o esterni (distrazioni). La digitalizzazione non modificherebbe, dunque, il nostro sistema cognitivo, ma lo asseconderebbe.
Si apre dunque un primo livello di discussione, non semplice: è necessario inseguire questa presunta natura disorganizzata della mente, oppure l’istruzione, così come concepita dalla nostra civiltà, deve forzare l’individuo a trovare forme di gerarchizzazione, per dare un ordine significativo al proprio sapere? Dobbiamo rispondere in modo ponderato, perché la modernità ha conosciuto uno sviluppo scientifico e culturale, negli ultimi quattro secoli, del tutto incomparabile – per velocità e risultati – con i quattro millenni che l’hanno preceduta. Con ciò si deve ritenere dunque che, quanto meno entro la concezione più diffusa di apprendimento, la didattica “tradizionale” fondata sul modello lineare della carta stampata, fatta di letture, ripetizioni, esercizi, traduzioni, riassunti, scritture e problemi sequenziali, ha ottemperato per secoli al compito di riproduzione e produzione culturale, si è perfezionata nel tempo e si è radicata nella coscienza educativa delle nostre società. E quindi, se ben proposta, quella modalità didattica svolge ancora il suo ruolo, e lo svolge piuttosto bene. Eppure comincia a presentare qualche incrinatura, nel suo scontro con le profonde trasformazioni sociali in atto.
Altre evidenze[4], tuttavia, ci inducono a ritenere che negli ultimi decenni (e nell’ultimo rapidissimamente, in particolare), si stiano diffondendo nuove modalità di relazione tra l’uomo e il testo (considerando “testo”, appunto, un sistema di simboli che dischiudono le porte a campi semantici più o meno complessi e variamente interpretabili), assumendo nuove geometrie e configurazioni, modificando attitudini cognitive, esigendo così una lenta e ponderata riconfigurazione del tipo di lavoro da svolgere nella scuola. Non è detto dunque che non si riveli necessario valutare modelli di organizzazione che non rispecchino più la linearità del libro stampato, ma che si muovano in una direzione reticolare.
Occorre ricordare due aspetti: i soggetti in età evolutiva sono costantemente immersi in un’imponente dinamica di processi di apprendimento extra-scolastico e informazionale del tutto priva di ogni linearità; secondariamente, i colossi della Rete (e delle sue varie applicazioni) agiscono sempre con il fine di manipolare i comportamenti di consumo, i gusti e le opinioni degli utenti, con lo scopo meccanico di aumentare il flusso di dati, e dunque i profitti. Non dimenticando mai questa duplice cornice, diventa importante l’istanza posta da Gui di insegnare agli studenti a costruire delle organizzazioni del sapere, criteri di ritenzione e scarto delle informazioni e dei linguaggi. Scrive infatti: “proprio l’abitudine più diffusa nel mondo digitale a uno stile comunicativo superficiale e frammentato dovrebbe suggerire una comprensione da parte delle scuole nella direzione dell’approfondimento e della linearità. Non è quindi vero che i giovani d’oggi hanno uno stile di apprendimento diverso. È vero piuttosto che essi sono più familiarizzati ad alcune pratiche cognitive che, se assolutizzate, possono anche diventare problematiche e controproducenti per l’apprendimento e il benessere. Quindi, i giovani (e noi con loro) vanno educati a contesti di apprendimento lineare, che non possiamo abbandonare del tutto, trovando le modalità per affiancare questa educazione alle pratiche digitali correnti”[5].
Si potrebbe opporre a questa posizione una rivendicazione degli effetti positivi della digitalizzazione sulla qualità dell’apprendimento. Ma anche su questo il sociologo procede in modo attento e ponderato: esiste un riscontro scientifico in riferimento ai presunti benefici del digitale nell’istruzione? Se teniamo in considerazione alcuni progetti di ricerca sperimentale, svoltisi tra gli anni Novanta e il Duemila, possiamo individuare alcuni software (a partire dal classico programma di videoscrittura) che, nel loro utilizzo per specifiche discipline, parrebbero aver prodotto progressi poco significativi, ma comunque osservabili, nei risultati di apprendimento. Si tratta comunque di un effetto (effect size) medio-lieve, misurato intorno allo 0,33%[6]. Una meta-analisi di livello ulteriore, tuttavia, ha messo in evidenza un fattore aggiuntivo, abbastanza ovvio: insegnare ricorrendo ad applicazioni digitali implica una diversa metodologia, per cui ogni possibile comparazione con la didattica tradizionale rischia di essere fuorviante: difficile stabilire se l’apporto positivo o negativo sia dovuto alle tecnologie, alla metodologia, o alla padronanza del docente che vi ricorre.
Risultati di alcune importanti indagini svolte invece su larga scala, in relazione alla massiccia implementazione di particolari tecnologie (ad esempio le LIM, o una capillare distribuzione di device[7]), registrano esiti non positivi, con effetti pressoché nulli nel confronto con i gruppi di controllo. Una conclusione, questa, confermata dai report dei test PISA del 2015[8].
Le ragioni di tali modesti risultati sono complesse, e se ne possono mettere in evidenza solo alcune. Certamente i docenti che apprendono a usare i dispositivi e i software in modo funzionale al proprio progetto didattico, acquisendo in ciò una certa maestria, riescono a potenziare la qualità del lavoro didattico, ma alcune abitudini strettamente legate all’uso dei dispositivi digitali (sia tra gli studenti che tra i docenti), si rivelano purtroppo deleterie. Secondo Müller e Oppeheimer, ad esempio, è possibile dimostrare che chi prende appunti con il PC durante lo svolgimento di una lezione, tende a trascrivere quello che ascolta, data la velocità di digitazione, ma lo trascrive in modo pressoché acritico[9]. Al contrario, chi prende appunti con il tradizionale blocco di carta e penna o matita, tende a rielaborare i contenuti contestualmente alla loro discussione o presentazione, favorendo un apprendimento significativo. Un’altra tipica modalità didattica, inizialmente abusata anche nei contesti aziendali, è data dalle presentazioni di slide. Tale strumento è stato riconosciuto come inefficace o controproducente per diverse ragioni, prima fra tutte la tendenza a rovesciare sui discenti una quantità eccessiva di informazioni. Gli studenti seguono le slide come seguirebbero un documentario, ma la loro rielaborazione e appropriazione dei contenuti è estremamente fragile, con effetti negativi sulla memorizzazione e fenomeni di dislocazione disfunzionale dell’attenzione[10].
Tra gli studi più interessanti, in questo campo d’indagine, ce ne sono alcuni che riguardano il grado di attenzione degli studenti in base alla vicinanza del proprio smartphone[11]. Pare che la fatica cognitiva impiegata per cercare di resistere alla tentazione di guardarlo inibisca fortemente la concentrazione sul compito. Altre analisi di forte attualità riguardano la resistenza media dei livelli attentivi durante le video-lezioni, che secondo le ricerche più accreditate non supererebbe i 6 minuti[12]: un dato assai demotivante per chi è costretto a presentare in video-conferenza dei contenuti molto complessi e non facilmente segmentabili. Ultimo punto critico, che agisce indirettamente sulla qualità dell’apprendimento, concerne il disturbo del sonno[13], evidentemente favorito dall’eccesso di esposizione agli schermi (secondo una ricerca condotta negli Stati Uniti, un cittadino trascorre mediamente davanti ai propri dispositivi digitali circa 6 ore al giorno, una quantificazione corrispondente a quella calcolata per i cittadini italiani nel 2019; a queste ore, inoltre, occorre aggiungere il tempo dedicato alla TV, che negli Stati Uniti mediamente prevede altre 6 ore giornaliere).
Tuttavia, ed è lo stesso sociologo a riconoscerlo, non è più possibile rinviare un’importante e incisiva azione didattica dedicata alla media education, la quale però si può costituire, a mio avviso, solo promuovendo anche la confidenza con procedure, sintagmi e logiche proprie del mezzo, in modo guidato dal docente (che dunque ne deve acquisire le competenze specifiche, conoscendone le implicazioni psico-antropologiche, senza giocare al “piccolo informatico”). Non è corretto ambire a costruire un’educazione ai media digitali senza veicolarla attraverso essi. Il punto critico è questo. La scuola deve riuscire a non perdere la propria capacità di forzare i processi cognitivi attraverso la costruzione di organizzazioni categoriali entro le quali dare ordine e cogliere le priorità nel flusso informazionale. Ma deve imparare a farlo anche utilizzando l’iper-connettività, e metabolizzando alcune alterazioni dei vissuti cognitivi e relazionali per produrre cultura.
Ma capisco le resistenze, soprattutto alla luce di quello che ormai viene definito “benessere digitale”. Secondo uno studio di Gui e Büchi, un rischio poco calcolato della proliferazione dei dispositivi (oggi massicciamente distribuiti con lo scopo dichiarato di contrastare il digital divide) è dato dal sovra-utilizzo: chi proviene da contesti sociali deboli, economicamente e culturalmente, tende a manifestare maggiori sintomi da dipendenza, oltre che un uso sostanzialmente povero e limitato a poche applicazioni social, dallo scarso impatto informativo[14]. Apprendere a distinguere il momento della concentrazione da quello dell’intrattenimento, a non farsi travolgere dalle notifiche e analoghi stimoli alla distrazione, ripristinare una naturale attenzione selettiva, è molto difficile, e deve rientrare in percorso formativo forte. Contemporaneamente, però, tale processo deve essere costruito senza uscire dal mare della connettività, pena l’irrilevanza.
Sappiamo dunque che il modello tradizionale della didattica frontale, ma interattiva, fondato sulla soggettività relazionale e sulla padronanza disciplinare del docente, resta un modello robusto, con il suo radicamento culturale e la sua pregnanza pedagogica. Tuttavia, cogliamo l’esigenza ormai improcrastinabile di mediare i processi di apprendimento entro la dimensione dell’iper-connettività. E allora, come lo stesso Gui sottolinea citando De Martin[15], dopo aver recepito il valore persistente del modello tradizionale (basato sulla didattica in presenza, sull’uso del libro di testo, scandito da interrogazioni e spiegazioni frontali et similia), la nostra necessità è capire quali alterazioni metodologiche indotte dalla trasformazione antropologica in corso (ad esempio introducendo i compiti di realtà) siano necessarie, o come le mediazioni digitali possono esserci utili per valorizzare e aggiornare il vecchio modello, invece di rimpiazzarlo del tutto. Se oltre a ricorrere agli strumenti digitali, non modifichiamo almeno in parte anche il nostro linguaggio e il nostro lavoro didattico, modellando con padronanza sempre maggiore la dimensione della connettività in base alle nostre esigenze pedagogiche, rischiamo di perseverare nel voler “dire la messa in latino”: tutti l’ascoltano e la rispettano, ma nessuno la capisce.
[1] M. Gui, Il digitale a scuola. Rivoluzione o abbaglio?, Il Mulino, Bologna 2019, p. 8.
[2] Cfr. G. Roncaglia, L’età della frammentazione. Cultura del libro e scuola digitale. Laterza, Roma-Bari 2020.
[3] A. Baricco, The Game, Einaudi, Torino 2018.
[4] P.C. Rivoltella e P. G. Rossi (a cura di), Tecnologie per l’educazione