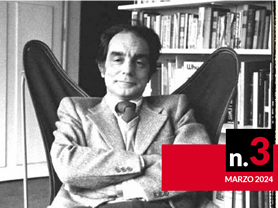Atenei liberi di scegliere e responsabili dei risultati
E' indispensabile che il governo capisca che oggi la ricchezza dipende dalla capacità di costruire istituzioni in grado di produrre e di trasmettere conoscenza


Francesco Grillo
«O xford è piacevole, ma vorrei che non fosse morta». Negli ultimi mesi mi è capitato di ripensare alle parole che scrisse in una lettera a un suo amico americano, quel Thomas Stern Eliot che cento anni fa raccontò l’impotenza degli intellettuali europei che osservavano l’Europa precipitare verso le Guerre mondiali. Dopo cento anni Oxford è più che mai viva, eppure nei grandi atenei inglesi e americani si percepisce di nuovo un senso di impotenza. La sensazione di non riuscire più neppure a comprendere fenomeni come quelli che hanno portato il Regno Unito fuori dall’Europa e gli Stati Uniti contro un ordine globale che loro stessi avevano inventato. E l’inadeguatezza di strumenti intellettuali rispetto a una trasformazione grande come le rivoluzioni industriali del passato.
L’Italia che inventò il metodo scientifico e che ha per anni subito la fuga della «parte migliore della propria gioventù», può paradossalmente trovare un’opportunità nella sfida cognitiva che il XXI secolo pone. Indispensabile, però, è che ci sia un governo che capisca che oggi la «ricchezza delle nazioni» non dipende da un qualche tasto spingendo il quale si «crea moneta». Ma dalla capacità di costruire istituzioni in grado di produrre e trasmettere conoscenza in un contesto nel quale è la creatività che torna al centro.
Certo, le università che abbiamo oggi in Italia sono amministrazioni pubbliche schiacciate dalle procedure. Che neppure sognano di poter ricominciare a immaginare soluzioni. Non c’è una sola università italiana tra le prime cento del mondo, anche se gli atenei più specializzati — il Sant’Anna, i Politecnici, la Bocconi — si difendono egregiamente. Tra i giovani italiani che hanno più di 25 e meno di 34 anni, solo un quarto sono laureati (precediamo solo il Messico tra i Paesi sviluppati). Lo Stato, del resto, investe in educazione — dagli asili ai dottorati — quattro volte di meno di ciò che spende in pensioni. Questo allineamento di rassegnazioni può condannarci a un declino senza fine.
Tuttavia, per un Paese come l’Italia sarebbe sbagliato continuare a osservare le università anglosassoni come un modello da imitare nella provincia dell’impero di un «pensiero unico» che non c’è più. Il problema è che le università sono sfidate in quanto istituzioni. Anche negli Stati Uniti sono, spesso, meno influenti di concorrenti più affamati e agili (le think tank e le imprese più visionarie). I cinesi attraggono quote crescenti di studenti dai Paesi in via di sviluppo e docenti che lasciano l’Europa. Lo stesso governo inglese ha cambiato il sistema di valutazione chiedendo agli atenei di dimostrare l’«impatto» concreto che hanno sui contribuenti che ne pagano il costo. E allontanandosi, finalmente, da un modello tutto basato sugli articoli scientifici che ci si scambia all’interno di comunità professionali chiuse.
Se vogliamo, dunque, far fare alle nostre università un salto dalla rassegnazione al progetto, dobbiamo, in primo luogo, riorganizzare gli atenei e le carriere dei docenti attorno ai problemi complessi (dall’impatto delle tecnologie sui settori industriali a quello sulle forme della democrazia) che attraversano le competenze e ai quali imprese e governi devono trovare risposte. E vanno aboliti i 367 settori scientifico-disciplinari nei quali il ministero ha spezzato l’università italiana in una federazione di piccoli poteri.
Va, poi, misurata — in maniera più concreta e comprensibile di quanto oggi non faccia l’Agenzia che fa valutazione (Anvur) — quanta conoscenza le università generano. Con criteri che vanno differenziati per incoraggiare gli atenei a specializzarsi per servire mercati nuovi: gli studenti internazionali; quelli a «distanza»; i lavoratori; gli anziani. È, del resto, la scelta dello studente (o della tipologia di studente che un ateneo dichiara di voler attrarre) la misurazione migliore della qualità del servizio fornito e sarebbe un errore azzerare le tasse universitarie che hanno, invece, il merito di incoraggiare chi studia a pretendere qualità.
In terzo luogo, va abbandonata l’idea che le imprese sono semplicemente clienti insoddisfatti. In realtà le imprese italiane sono state parte del problema: i numeri dell’Oecd dimostrano che il premio di un anno in più di studio è in Italia inferiore alle medie europee. Progetti come quelli dei dottorati industriali devono diventare ricerche su temi di frontiera sui quali comunità locali, clusters di imprese, amministrazioni e università si giocano il futuro.
Infine, le bandiere che nella guerra di trincea sulla riforma delle università si sono contrapposte per anni. Autonomia, a partire da quella che nel reclutamento dei docenti che va riconosciuta agli atenei ai quali è chiesto di sopravvivere al cambiamento. E risorse, a cominciare da quelle che incoraggino gli studenti a ritornare all’idea classica di università come esperienza da vivere in viaggio, lontani da casa. In realtà, tra i due termini non c’è nessuna scelta da fare: solo università libere di scegliere e responsabili dei risultati, avranno la forza politica di chiedere investimenti drasticamente maggiori.
Nei prossimi anni nulla sarà più impossibile. Paesi rimasti indietro possono trovare nella rivoluzione tecnologica le leve per superare chi è davanti. L’Italia può ritrovare prospettiva, solo scoprendo la memoria di se stessa: questa è la sfida per chi volesse governare con una logica che non può più essere quella dell’amministrazione della cris i.
La nostra rivista online
Servizi e comunicazioni
Seguici su facebook
I più letti
-
 Istruzione e ricerca: basta con la precarietà
Istruzione e ricerca: basta con la precarietà
-
 Scuola, università e ricerca: un esercito di 300mila precari. Il rapporto Cgil fotografa una situazione “in costante peggioramento”
Scuola, università e ricerca: un esercito di 300mila precari. Il rapporto Cgil fotografa una situazione “in costante peggioramento”
-
 Scuola, FLC CGIL: servono 4 miliardi in più per abbattere la precarietà
Scuola, FLC CGIL: servono 4 miliardi in più per abbattere la precarietà
-
 Scuola, servono 4 miliardi per stoppare il precariato e portare l’obbligo a 18 anni. Calcolo Flc-Cgil. Piange pure l’Università col 49% di supplenti
Scuola, servono 4 miliardi per stoppare il precariato e portare l’obbligo a 18 anni. Calcolo Flc-Cgil. Piange pure l’Università col 49% di supplenti