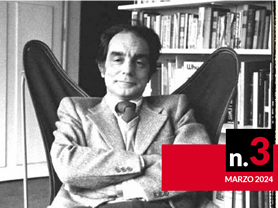La Buona Università? Deve puntare sulla didattica, non solo sulla ricerca
Stefanio Semplici, docente di Etica sociale a Tor Vergata, riflette sui mali dell’accademia italiana (e sui possibili rimedi) in vista della riforma annunciata dal governo


La «buona università» ha certamente bisogno di più risorse e professori. E la retorica a buon mercato sul «sapere come risorsa strategica per lo sviluppo» rende solo più dolorosa la cruda evidenza dei numeri. Tutte le graduatorie internazionali ci vedono malinconicamente agli ultimi posti fra i paesi più avanzati per gli investimenti in istruzione terziaria. Fra il 2007 e il 2015 il numero dei docenti ordinari delle università italiane è sceso da poco meno di 20.000 a poco più di 13.000. Dove vogliamo fermarci? Per quanto tempo ancora gli sprechi e le inefficienze di alcuni (o anche di molti) saranno utilizzati come un pretesto per soffocare tutti, mentre i nostri giovani migliori se ne vanno, portando con sé buona parte delle speranze della loro generazione?
Darwinismo accademico
Su due punti, tuttavia, sembra impossibile anche solo aprire un confronto. E forse non è un caso, perché si tratta del risultato di scelte perseguite con granitica coerenza in questi ultimi anni da maggioranze molto diverse. Il darwinismo accademico e la didattica senza merito sono ormai subiti come la conseguenza inevitabile della cultura della valutazione, della qualità e dell’efficienza. Si può provare almeno a dubitare che siano strumenti indispensabili per raggiungere questo obiettivo, ovviamente condiviso? Gli effetti della competizione esasperata fra singoli ricercatori, dipartimenti ed atenei sono noti, a partire dai comportamenti opportunistici finalizzati a massimizzare l’impatto del proprio lavoro nel breve periodo, prosciugando i talenti e la passione del pensare lungo. Le classifiche che mettono in fila le università sono diventate un’ossessione mediatica e le regole che le producono, oltre a generare le più incredibili vessazioni burocratiche, alimentano la convinzione che l’obiettivo fondamentale da perseguire non sia quello di fare bene il proprio lavoro aiutando gli altri a fare lo stesso, ma quello di sopravanzarli in qualche modo ed essere «premiati». Si dimentica così che la vera alternativa non è fra produttivi e sfaccendati, perché nessuno difende ovviamente i secondi, ma fra quanti ritengono che una seria valutazione serva appunto a premiare e punire (con il risultato che diventerà sempre più difficile, per chi è rimasto indietro, recuperare) e quanti sono invece convinti che le stesse punte di eccellenza abbiano bisogno per sostenersi di una base ampia e solida di metodologie e buone pratiche condivise. Una qualità media dignitosa e diffusa sul territorio è sempre stata la caratteristica del nostro sistema e questa ricchezza, la cui difesa non è incompatibile con la valorizzazione dei migliori risultati, rischia di andare perduta. Ne è prova il fatto che cresce il numero dei giovani del Mezzogiorno che vanno a studiare lontano da casa. È stato un errore grave quello che ha portato a dare ad ogni campanile la sua università. Ma siamo sicuri che lo Stato si debba adesso limitare a certificare i risultati di una lotta senza quartiere, che sta portando alla desertificazione universitaria di intere aree del paese?
Didattica senza merito
La didattica senza merito è la conseguenza di una politica universitaria che ha ancorato in modo ossessivo la valutazione ai soli «prodotti» della ricerca, riducendo di fatto la «prima» missione dell’università ad un ruolo marginale e sistematicamente «disincentivato». La stessa proposta di differenziare researching e teaching universities è stata declinata come uno strumento di gerarchizzazione delle funzioni, mentre si stratificavano interventi normativi a senso unico. La didattica e la capacità di insegnare non contano ai fini della carriera accademica. Lo stabiliva già la legge Gelmini. La didattica non conta neanche per chi è diventato professore: le politiche di reclutamento del personale da parte degli atenei sono valutate in base ad una serie di criteri fra i quali non figura la qualità dell’insegnamento, mentre spicca al primo posto la produzione scientifica. E sulla base di quest’ultima viene assegnata la quasi totalità della «quota premiale» del Fondo di Finanziamento Ordinario delle università. Non c’è bisogno di insegnare, insomma, per essere buoni professori. E si possono esonerare i migliori dal dovere della trasmissione del sapere che contribuiscono a produrre, perché tanto «si troverà qualcuno da mandare in aula». Se non si corregge questo paradosso, sarà molto difficile trovare la strada della buona università. E non basterà un altro Jobs Act. Che comporta per inciso, come dovrebbe sempre aggiungere chi lo propone come rimedio anche in questo settore, la possibilità del licenziamento senza giustificato motivo, con una indennità “di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento” e in misura “non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”. Non sembra francamente questa la soluzione migliore per rafforzare l’autonomia e la libertà delle università e di chi in esse vive e lavora. E dirlo non significa schierarsi a difesa di “baroni” e fannulloni.
La nostra rivista online
Servizi e comunicazioni
Seguici su facebook
I più letti
-
 Istruzione e ricerca: basta con la precarietà
Istruzione e ricerca: basta con la precarietà
-
 Scuola, università e ricerca: un esercito di 300mila precari. Il rapporto Cgil fotografa una situazione “in costante peggioramento”
Scuola, università e ricerca: un esercito di 300mila precari. Il rapporto Cgil fotografa una situazione “in costante peggioramento”
-
 Scuola, FLC CGIL: servono 4 miliardi in più per abbattere la precarietà
Scuola, FLC CGIL: servono 4 miliardi in più per abbattere la precarietà
-
 Scuola, servono 4 miliardi per stoppare il precariato e portare l’obbligo a 18 anni. Calcolo Flc-Cgil. Piange pure l’Università col 49% di supplenti
Scuola, servono 4 miliardi per stoppare il precariato e portare l’obbligo a 18 anni. Calcolo Flc-Cgil. Piange pure l’Università col 49% di supplenti