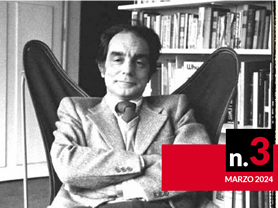https://www.flcgil.it/@3921483
L'università che non insegna
L’università italiana da mesi è un po’ oscurata nei racconti dei media sulla (buona?) scuola, e forse nessuno si è accorto del disagio che sta vivendo
23/03/2015




la Repubblica
MARIO PIRANI
L’ITALIA dedica alla spesa pubblica per l’istruzione — in larga parte scuola ed università — l’8,5% del totale delle risorse a disposizione, contro una media del 12,5% dei Paesi più ricchi appartenenti all’Ocse ed un 15,5% degli Stati Uniti. L’università italiana da mesi è un po’ oscurata nei racconti dei media sulla (buona?) scuola, e forse nessuno si è accorto del disagio che sta vivendo. Eppure l’Europa su di essa ha scommesso in maniera rilevante: chiedendo, ad esempio, che ogni Paese si impegni affinché tra i suoi trentenni vi siano — sin dal 2020 — almeno il 40% dei laureati. Restiamo clamorosamente al palo, ultimi (!) tra i Paesi dell’Unione europea con un misero 23%, quando molti tra questi hanno già raggiunto il traguardo.
Accade continuamente che i migliori studenti dei corsi triennali chiedano ai loro docenti dove dovranno proseguire i loro studi e li si spinge quasi sempre ad andare all’estero. È un suggerimento in buona fede o piuttosto una resa inconsapevole che cela un disinteresse verso di loro? I laureati diminuiscono e le statistiche ci dicono che la probabilità di concludere gli studi universitari dipende ancora in modo significativo dalla classe sociale di provenienza dei genitori: i meno abbienti continuano a diffidare di una formazione poco attraente, sempre più la classe medio-alta, d’altronde, decide di finanziare i trasferimenti della prole in atenei esteri, Europa, Stati Uniti e Canada principalmente.
Se non abbiamo tanti laureati evidentemente ci sono poche, e non tante, università, pochi e non tanti ricercatori e professori. Le ragioni di questo disimpegno, avvenuto in maniera sempre più significativa in quest’ultimo decennio, sono tante. A cominciare ovviamente dalle risorse: ridotte drasticamente da Tremonti in maniera strutturale, non sono state rimpinguate dal governo Renzi. Il noto sito Roars sull’università italiana mostra come complessivamente, il minor finanziamento da qui al 2023 ammonta a quasi un miliardo e mezzo di euro, una cifra poco minore del taglio Tremonti. Come pensare con queste cifre di poter raddoppiare il numero di laureati come ci chiede l’Europa? Non è ovviamente soltanto una questione di risorse. Rendere l’università più attraente per gli studenti implica innanzitutto fargli percepire non solo la possibilità di un buon lavoro ma anche di apprendere metodi di conoscenza innovativi e interdisciplinari. E qui i numeri nuovamente non confortano: il surplus di remunerazione oraria per i laureati italiani è tra i più bassi d’Europa e i metodi di studio e apprendimento sono spesso antiquati o impediti da strutture inadeguate.
I docenti lamentano una crescente burocratizzazione nel loro lavoro, impegnati come sono a compilare schede spesso copiate ed incollate da quelle di altri colleghi di altre università. I più anziani rinfacciano ai giovani di non volersi più sporcare le mani con i corsi dei primi anni in aule spesso piene di studenti, per preferire corsi più elitari di pochi dottorandi con i quali magari scrivere un lavoro in più, a doppia firma, e arricchire il curriculum garantendo maggiori possibilità di passare il concorso per associato o ordinario. Così facendo precludono ai tanti giovanissimi che ancora si affacciano al mondo universitario di conoscere gli avanzamenti più recenti della ricerca scientifica o classica, spesso meglio padroneggiati dagli studiosi più giovani. Ma c’è poco da stupirsi se questo avviene: le nuove regole dei concorsi mirano a premiare principalmente la ricerca, relegando la didattica, così essenziale per i suoi positivi effetti a cascata sui discenti, a sforzo inutile perché poco premiato.
Eppure c’è, tra i professori universitari, chi rimane in trincea in Italia e cerca di darsi da fare, puntando spesso all’internazionalizzazione dei propri corsi, in lingua inglese. Tuttavia, in mancanza di fondi, questi sono costretti ad aumentare le tasse universitarie per invitare professori stranieri, per dare servizi extra che le università di altri Paesi europei offrono regolarmente. Occorre ripensare a una carriera universitaria basata solo sulla ricerca, benché, se fatta seriamente, molto importante. È necessario riqualificare la didattica, attraverso valutazioni oggettive sui docenti, i cui risultati incidano sul punteggio dei concorsi universitari, al fine di far perdere la sensazione, che molti studenti universitari hanno, di essere un inciampo nel frenetico movimento dei loro professori.
La nostra rivista online
Servizi e comunicazioni
Seguici su facebook
I più letti
-
 Istruzione e ricerca: basta con la precarietà
Istruzione e ricerca: basta con la precarietà
-
 Scuola, università e ricerca: un esercito di 300mila precari. Il rapporto Cgil fotografa una situazione “in costante peggioramento”
Scuola, università e ricerca: un esercito di 300mila precari. Il rapporto Cgil fotografa una situazione “in costante peggioramento”
-
 Scuola, FLC CGIL: servono 4 miliardi in più per abbattere la precarietà
Scuola, FLC CGIL: servono 4 miliardi in più per abbattere la precarietà
-
 Scuola, servono 4 miliardi per stoppare il precariato e portare l’obbligo a 18 anni. Calcolo Flc-Cgil. Piange pure l’Università col 49% di supplenti
Scuola, servono 4 miliardi per stoppare il precariato e portare l’obbligo a 18 anni. Calcolo Flc-Cgil. Piange pure l’Università col 49% di supplenti