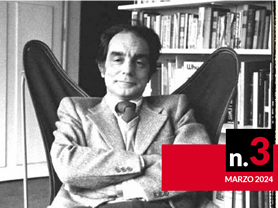Io voto Socrate
di Alessandro D'Avenia


«Molte volte, conoscere se stessi, Socrate, mi è sembrata una cosa alla portata di tutti. Molte volte, invece, assai difficile». Così Alcibiade manifestava al maestro la sua preoccupazione di fronte alla fatica che comporta crescere. Socrate gli rispose: «Alcibiade, che sia facile oppure no, conoscendo noi stessi potremo sapere come dobbiamo prenderci cura di noi, mentre se lo ignoriamo, non lo potremo proprio sapere».
Qualsiasi riforma della scuola dovrebbe partire dall’affermazione di Socrate, che pone come fine della conoscenza la cura di se stessi e quindi del mondo. Nei fatti, però, il sapere al servizio della cura dell’uomo è oggi quasi impossibile in una scuola immobilizzata dalla burocrazia, corrosa dal precariato dei docenti giovani e dal cosiddetto burn-out, in italiano «bruciare completamente», dei meno giovani, «bruciati, scoppiati», potremmo dire, non per l’ordinario stress da lavoro, ma a causa di un vero e proprio esaurimento emotivo, figlio della mancanza di senso e riconoscimento per ciò che si fa. La demotivazione degli insegnanti, in un sistema che ne trascura la dignità, genera la corrispondente apatia nei ragazzi, privati così dell’essenza della scuola: l’orientamento, cioè l’aiuto prestato a un giovane in formazione per intercettare la parte di realtà in cui riuscirà a mettere in gioco il meglio di sé.
Ed è proprio perché manca l’orientamento che troppi studenti lasciano la scuola, ritirandosi o anche solo arrendendosi mentalmente, incapaci di cogliere il proprio futuro: la formazione, senza orientamento, è sterile, non serve alla vita, alla presa sulla vita. Si sentono oggetti da prestazione e non soggetti di possibilità, atomi isolati e non storie che portano il nuovo nel mondo. E non possiamo stupirci se la naturale tensione al compimento di sé, quando non trova una meta, si corrompe in apatia o in violenza.
«Frequento la quinta superiore e non ho la più pallida idea di cosa voglio fare della mia vita (che cosa hanno fatto fino ad adesso gli insegnanti con me?). Come faccio a capire qual è la mia vocazione? Non mi aspetto una soluzione al problema, però ti chiedo se puoi aiutarmi a capire quali possono essere i criteri e i modi per scoprire ciò a cui sono chiamata». Ricevo da tantissimi studenti lettere come questa, a conferma che l’essere umano si definisce come tale solo se riesce a dar senso, significato e direzione, alla propria vita nel mondo che lo circonda: cioè impara ad abitarlo anziché subirlo. In questo senso i docenti sono mentori, guide per temporanei «non vedenti»: i ragazzi, con la vista ancora un po’ annebbiata, imparano passo passo ad orientarsi arrivando poi a «vedere» davvero.
Alla fine di 13 anni di scuola sono tantissimi i ragazzi che non sanno molto di sé. Per questo sono paralizzati dalla paura, come mostra il crescente fenomeno dei cosiddetti Neet (acronimo inglese di «not in education, employment or training»), cioè giovani che non studiano né lavorano, in Italia più di 2 milioni, di cui si è occupato Alessandro Rosina nel libro dedicato al nostro potenziale perduto proprio per l’inefficienza nella transizione scuola-lavoro. E questo dipende in gran parte dal fatto che la scuola non aiuta a scovare le proprie attitudini. Molti dopo le medie non sanno che strada intraprendere: liceo (quale?), formazione professionale, tecnica? Ricevono consigli approssimativi e, nei casi virtuosi, qualche test attitudinale. Spesso si finisce così per scegliere «cosa fanno gli amici» o «cosa dicono i genitori». Lo stesso accade alla fine delle superiori: fare o no l’università? Quale facoltà? Quale lavoro? Troppi sbagliano percorso, arrancano, cambiano, magari per scelte basate su copioni rassicuranti ma poco rispondenti alle reali attitudini. Il futuro si apre solo quando sboccia da dentro, non quando è mero contagio esteriore. L’orientamento all’ultimo anno si riduce a un catalogo di open-day; l’obiettivo delle università è attirare i ragazzi, spesso anticipando i test per vincolarli all’iscrizione preventiva, ignorando il peso del percorso di studi e dell’esame di maturità: in altre parole, ignorando la loro storia.
Nella scuola attuale l’orientamento è affidato al «volontariato» dei professori, quasi fosse una missione umanitaria e non un atto professionale richiesto dall’articolo 3 della Costituzione: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». L’assenza di orientamento a scuola è causa di ingiustizia sociale, come spiegano due libri recentissimi che, partendo da impostazioni molto diverse, arrivano alla stessa conclusione: Federico Fubini, La maestra e la camorrista - Perché in Italia resti quello che nasci e Christian Raimo, Tutti i banchi sono uguali - La scuola e l’uguaglianza che non c’è . I due autori mostrano che la scuola italiana invece di essere un ascensore sociale è, al meglio, un adattatore sociale, al peggio, causa e conferma delle disuguaglianze di partenza: non porta novità, ma tacito adeguamento. L’alternanza scuola-lavoro si sta dimostrando, soprattutto nei licei, un’illusione di orientamento, che spesso catapulta i ragazzi in realtà inadatte alle loro attitudini o avulse dal lavoro reale. Mandarli a «lavorare» senza prima aver capito qual è la «bottega» in cui mettere a frutto i propri talenti, rende il lavoro una finzione che di orientativo e formativo ha poco.
Per queste ragioni a metà maggio cerco di concludere lezioni e verifiche per dedicarmi all’esplorazione dei talenti, coinvolgendo genitori e colleghi. È risultato efficace un percorso di scrittura autobiografica. Attraverso le tecniche del genere i ragazzi provano a scrivere la loro autobiografia, cosa che li costringe alla riflessività: oggi è il punto nevralgico della conoscenza di sé, ostacolata dallo stile cognitivo frammentario tipico della rete. I ragazzi si sorprendono del potere esplorativo della scrittura, della propria grafia su un foglio bianco che somiglia alla loro anima, su cui hanno finalmente presa. Garantendo la continuità didattica (avere la classe per un ciclo intero dovrebbe essere la normalità), si potrebbero dedicare di anno in anno, letture, incontri e test mirati a scovare e coltivare gli interessi di ciascuno. Sogno una scuola così perché è stato fatto così con me e questo mi ha portato a scelte tanto difficili quanto felici. Un professore-mentore, quando ero combattuto tra seguire le orme paterne come dentista, con uno studio già pronto, e intraprendere l’ardua strada dell’insegnamento («sarai un morto di fame, sii realista» mi dicevano in tanti), mi chiese: hai 40 anni, cosa fai? Vai in studio a curare denti o in classe a raccontare storie? L’immagine fu risolutiva, ridimensionai molte paure per abbracciare più avvincenti incertezze, lasciando la mia città per studiare lettere classiche in un’altra che offriva corsi più adeguati. Ora che ho 40 anni ripenso a quella frase con grata commozione.
Solo chi ha vocazione provoca vocazioni, cioè nuove coraggiose esplorazioni del mondo. Il passo successivo è infatti scegliere «la bottega» dove imparare. Quando la madre di un dodicenne di provincia chiese al figlio che cosa volesse fare da grande e lui rispose con sicurezza: il pittore, lei lo prese sul serio e impegnò tutti i risparmi per mandarlo a Milano a bottega da un maestro. Il dodicenne, scrive un biografo, «studiò in fanciullezza per quattro o cinque anni, con diligenza ancorché di quando in quando facesse qualche stravaganza causata da quel calore e spirito così grande». E divenne Caravaggio.
Non riuscirei a fare l’insegnante senza prendere sul serio la vita futura dei ragazzi e credo sia questo il letto da rifare oggi, come richiesto dalla lettera riportata sopra. Socrate fu condannato a morte perché insegnava «nuove divinità e corrompeva i giovani», quando semplicemente li portava a riconoscere il proprio daimon, una forza interiore, a metà tra cielo e terra, che spinge al compimento di sé trasformando un destino in destinazione: «è qualcosa che è cominciato da bambino, come una specie di voce», così la definisce nella sua vana autodifesa. Potremmo per questo chiamarla: vocazione. Finché la scuola non rimetterà al centro la storia intera di un ragazzo, la sua voce, egli penserà che formarsi non serva a una vita migliore. I numeri della nostra dispersione scolastica (quintultimi in Europa, il 14% abbandona gli studi) confermano un sistema che fatica a mostrare che conoscere è prendersi cura di sé, e poi del mondo attraverso un lavoro.
Basterebbe dedicare le 200 (licei) o 400 (tecnici e professionali) ore dell’alternanza scuola-lavoro a un orientamento ben fatto per salvare tante voci, tante vocazioni. Cominciamo?
La nostra rivista online
Servizi e comunicazioni
Seguici su facebook
I più letti
-
 Istruzione e ricerca: basta con la precarietà
Istruzione e ricerca: basta con la precarietà
-
 Scuola, università e ricerca: un esercito di 300mila precari. Il rapporto Cgil fotografa una situazione “in costante peggioramento”
Scuola, università e ricerca: un esercito di 300mila precari. Il rapporto Cgil fotografa una situazione “in costante peggioramento”
-
 Scuola, FLC CGIL: servono 4 miliardi in più per abbattere la precarietà
Scuola, FLC CGIL: servono 4 miliardi in più per abbattere la precarietà
-
 Scuola, servono 4 miliardi per stoppare il precariato e portare l’obbligo a 18 anni. Calcolo Flc-Cgil. Piange pure l’Università col 49% di supplenti
Scuola, servono 4 miliardi per stoppare il precariato e portare l’obbligo a 18 anni. Calcolo Flc-Cgil. Piange pure l’Università col 49% di supplenti